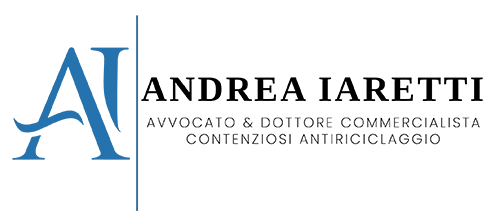- Sentenza: 36 – Dottore commercialista sanzionato per omessa S.O.S.
36 – Dottore commercialista sanzionato per omessa S.O.S.
Commercialista. Corte d’Appello di Roma. Provenienza o destinazione illecita dei fondi ?
La recente sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata 04/2025 rappresenta un importante punto di riferimento nell’interpretazione degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio, delineando con chiarezza i confini tra provenienza e destinazione illecita dei fondi nell’ambito del decreto legislativo 231/2007.
Il caso di primo grado: la decisione del Tribunale di Roma
La vicenda giudiziaria d’Appello ha origine con la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata 11/2021, che aveva accolto l’opposizione di un commercialista contro un decreto sanzionatorio del MEF. Il professionista era stato sanzionato per 52.000 euro per aver omesso la segnalazione di operazioni sospette relative a due bonifici bancari di 250.000 e 270.000 euro, effettuati nel 2010 da una società poi dichiarata fallita verso una società turca, in esecuzione di un contratto di consulenza.
Il Tribunale aveva annullato la sanzione ritenendo che l’obbligo di segnalazione non sussistesse quando il denaro movimentato risulti di provenienza lecita, indipendentemente da qualsiasi valutazione giuridica della movimentazione in sé. Secondo i giudici di primo grado, non risultava dagli atti alcun elemento da cui desumere la provenienza criminosa della provvista utilizzata, dovendosi tutt’al più ritenere che tale provvista fosse stata destinata ad un’attività illecita di depauperazione del patrimonio in danno dei creditori.
L’appello del MEF e la conferma della Corte d’Appello
Il MEF ha impugnato la sentenza sostenendo che essa risultava contraddittoria, ritenendo non configurabile l’illecito in assenza di ipotesi di riciclaggio, pur in presenza di plurimi indicatori di anomalia, ma nel contempo rilevando che il professionista, consapevole della situazione prefallimentare della società, potesse rendersi conto della portata fittizia e distrattiva dell’operazione.
La Corte d’Appello ha respinto l’appello, confermando integralmente l’orientamento del Tribunale e fornendo una ricostruzione sistematica dei principi in materia di segnalazioni antiriciclaggio.
I principi di diritto consolidati dalla Corte d’Appello
La definizione di riciclaggio e i suoi presupposti
La Corte ha richiamato la definizione di riciclaggio contenuta nell’articolo 2 del decreto legislativo 231/2007, rimasta invariata dopo la novella del 2017, evidenziando come l’operazione di riciclaggio presupponga necessariamente “la conoscenza della provenienza del denaro o dei beni impiegati da un’attività criminosa, dunque da un’attività delittuosa non colposa”.
L’evoluzione normativa: dall’articolo 41 all’articolo 35
La sentenza analizza l’evoluzione della disciplina dall’articolo 41 del decreto legislativo 231/2007 nella formulazione originaria all’attuale articolo 35, come modificato dal decreto legislativo 90/2017. Mentre la formulazione previgente richiedeva il sospetto che fossero “in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”, la normativa attuale aggiunge anche il sospetto “che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”.
Il sospetto rilevante ai fini dell’obbligo di segnalazione
La Corte ha chiarito che il sorgere dell’obbligo di segnalazione non è subordinato alla certezza o alla diretta conoscenza che il cliente abbia posto in essere operazioni finalizzate al riciclaggio, essendo sufficiente anche l’esistenza di un sospetto semplice, non qualificato da ulteriori indizi. Tuttavia, è necessario che la segnalazione presupponga “una valutazione sull’idoneità dell’operazione, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento, l’occultamento, la dissimulazione, l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni provenienti da una attività criminosa”.
La distinzione fondamentale: provenienza versus destinazione illecita
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra provenienza e destinazione illecita dei fondi. La Corte ha stabilito con chiarezza che “se i beni hanno provenienza lecita non può esservi motivo di sospetto né obbligo di segnalazione all’UIF”, precisando che “non va confusa con un’operazione di riciclaggio nel senso anzidetto né può costituire motivo di sospetto ai fini dell’integrazione della fattispecie illecita la possibilità che per effetto del successivo trasferimento del denaro possa configurarsi un illecito”.
Nel caso specifico, il denaro impiegato per i bonifici proveniva dal conto corrente della società e da questa normalmente impiegato per il pagamento di clienti e fornitori. La contestazione era imperniata sulla destinazione presuntivamente illecita dei fondi utilizzati e non sulla provenienza illecita degli stessi, configurando un piano di spoliazione patrimoniale in danno dei creditori, ma non un’operazione di riciclaggio.
Le implicazioni pratiche per i professionisti
Criteri di valutazione per l’obbligo di segnalazione
La sentenza fornisce importanti indicazioni operative per i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio. L’obbligo di segnalazione sorge quando sussistano elementi che facciano ragionevolmente sospettare:
- La provenienza criminosa dei beni o del denaro impiegato nell’operazione
- Che l’operazione sia connessa ad attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
- L’idoneità dell’operazione ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio
Operazioni distrattive e patrimonio sociale
Particolare rilevanza assume il chiarimento secondo cui le operazioni finalizzate alla diminuzione della garanzia patrimoniale di una società in danno dei creditori, pur configurando potenziali illeciti, non integrano automaticamente i presupposti per l’obbligo di segnalazione se i fondi utilizzati hanno provenienza lecita.
Il consolidamento giurisprudenziale
La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato che, come evidenziato dalla Corte attraverso i richiami alle sentenze di Cassazione nn. 25735/2017, 11440/2024 e 29395/2024, richiede sempre una valutazione sull’idoneità dell’operazione ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio, non limitandosi alla mera presenza di anomalie formali.
Massima di diritto
La Corte d’Appello ha formulato il seguente principio di diritto: “L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007 nella formulazione previgente e dall’art. 35 del medesimo decreto come novellato dal D.Lgs. n. 90/2017 presuppone necessariamente il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto deve indirizzarsi verso la provenienza dei beni impiegati da un’attività criminosa, con la conseguenza che se i beni hanno provenienza lecita non può esservi motivo di sospetto né obbligo di segnalazione. Non costituisce operazione di riciclaggio né può integrare motivo di sospetto la mera possibilità che per effetto del successivo trasferimento del denaro di provenienza lecita possa configurarsi un illecito, dovendo distinguersi tra la provenienza illecita dei fondi e la loro destinazione potenzialmente illecita”.
Conclusioni e prospettive applicative
La sentenza della Corte d’Appello di Roma rappresenta un importante punto di riferimento per l’interpretazione degli obblighi antiriciclaggio, fornendo criteri chiari per distinguere tra situazioni che richiedono segnalazione e quelle che, pur presentando profili di anomalia, non integrano i presupposti normativi per l’obbligo di comunicazione all’UIF.
La decisione conferma l’approccio sostanzialista nell’interpretazione della normativa antiriciclaggio, richiedendo sempre una valutazione concreta dell’idoneità dell’operazione ad essere strumento di riciclaggio, piuttosto che limitarsi alla presenza di indicatori formali di anomalia. Questo orientamento fornisce maggiore certezza ai professionisti nell’adempimento dei propri obblighi, delineando con precisione i confini tra condotte sanzionabili e operazioni che, pur presentando elementi di irregolarità, non rientrano nell’ambito applicativo della disciplina antiriciclaggio.
La distinzione tra provenienza e destinazione illecita dei fondi costituisce quindi un criterio fondamentale per l’applicazione corretta della normativa, evitando interpretazioni estensive che potrebbero comportare un’eccessiva burocratizzazione degli adempimenti a carico dei soggetti obbligati, senza corrispondenti benefici in termini di prevenzione del riciclaggio.