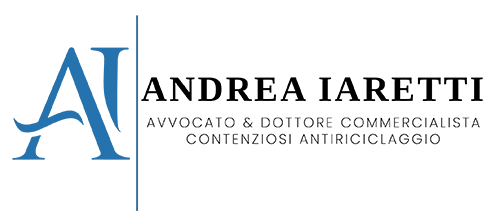- Sentenza: 35 – Sent. Corte d’Appello di Roma 12/2024 – società fiduciaria
35 – Sent. Corte d’Appello di Roma 12/2024 – società fiduciaria
Società fiduciaria. La Corte d’Appello di Roma e la disciplina Antiriciclaggio, la Sentenza 12/2024.
Introduzione
La normativa antiriciclaggio rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di prevenzione dei reati finanziari nel nostro ordinamento. La sentenza della Corte d’Appello di Roma 12/2024 offre importanti spunti di riflessione sull’applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, fornendo chiarimenti significativi sui profili di responsabilità e sulle modalità di quantificazione delle sanzioni amministrative.
La vicenda processuale
La controversia trae origine da un procedimento sanzionatorio avviato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti di una società fiduciaria e del suo legale rappresentante per presunte violazioni degli obblighi antiriciclaggio. Il caso si inserisce nel contesto delle operazioni di scudo fiscale disciplinate dall’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, evidenziando la complessità interpretativa che caratterizza l’intersezione tra normativa tributaria e disciplina antiriciclaggio.
Il procedimento di primo grado aveva visto l’accoglimento parziale dell’opposizione proposta dai sanzionati, con una significativa riduzione dell’importo della sanzione originariamente irrogata. Il MEF aveva quindi proposto appello, contestando la decisione del Tribunale e richiedendo il ripristino della sanzione nella misura originariamente determinata.
I principi affermati dalla Corte d’Appello
Responsabilità del legale rappresentante
La Corte d’Appello ha chiarito un aspetto fondamentale relativo all’imputazione della responsabilità per le violazioni antiriciclaggio. Nel caso di specie, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette gravava direttamente sul legale rappresentante della società fiduciaria, in assenza di una specifica organizzazione interna della funzione antiriciclaggio con individuazione di soggetti delegati.
Questo principio assume particolare rilevanza considerando che, all’epoca dei fatti del 2009, non era ancora obbligatoria la costituzione di un presidio antiriciclaggio interno, divenuto tale solo con la Circolare della Banca d’Italia del 2011. La Corte ha precisato che, in assenza di prova dell’effettiva nomina dell’organo di controllo, la responsabilità per l’omessa segnalazione ricade necessariamente sul legale rappresentante dell’ente.
L’elemento soggettivo della violazione
Un aspetto di particolare interesse riguarda la configurazione dell’elemento soggettivo della violazione. La Corte ha ribadito che tale elemento si presume ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gravando sull’agente l’onere di dimostrare di aver agito senza colpa. Questa impostazione conferma l’orientamento consolidato che privilegia la funzione preventiva della normativa antiriciclaggio rispetto alle tradizionali categorie del diritto sanzionatorio.
Le operazioni di Scudo Fiscale e gli obblighi di segnalazione
La sentenza affronta una questione di notevole complessità tecnica relativa all’applicazione degli obblighi antiriciclaggio nelle operazioni di scudo fiscale. La Corte ha chiarito che l’esenzione dall’obbligo di segnalazione opera esclusivamente per i reati tributari specificatamente indicati dalla normativa e per le condotte di falso, rimanendo validi gli obblighi di segnalazione per illeciti diversi da quelli richiamati.
Questo principio assume particolare rilevanza pratica, poiché stabilisce che anche quando i motivi di sospetto emergano successivamente al perfezionamento delle operazioni di rientro dei capitali, permane l’obbligo di segnalazione per le fattispecie non coperte dall’esenzione normativa.
Il concetto di sospetto di riciclaggio
La Corte ha fornito una definizione particolarmente significativa del concetto di “sospetto di riciclaggio”, chiarendo che esso non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario specifico né all’esclusione dell’estraneità delle operazioni ad attività delittuosa. Il giudizio deve essere obiettivo e basato sull’idoneità delle operazioni ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio.
Questa impostazione riflette la funzione di mero filtro delle segnalazioni e la ratio preventiva della normativa, che sanziona una condotta di pericolo piuttosto che di danno effettivo.
Gli elementi di anomalia
La sentenza individua specifici elementi di anomalia che possono generare l’obbligo di segnalazione:
- L’evidente sproporzione tra le disponibilità finanziarie scudate e il profilo economico del cliente
- La partecipazione di dipendenti pubblici a compagini societarie commerciali con collegamenti a soggetti coinvolti in indagini penali
- La detenzione di cospicue disponibilità presso intermediari esteri da parte di soggetti con redditi modesti
- Il coinvolgimento del cliente in procedimenti penali per reati non coperti dallo scudo fiscale
La quantificazione della sanzione
Un aspetto di particolare interesse pratico riguarda i criteri per la determinazione dell’importo della sanzione. La Corte ha stabilito che la quantificazione deve considerare diversi elementi:
- L’assenza di precedenti violazioni
- La collaborazione prestata durante il procedimento
- La capacità finanziaria degli incolpati
- La gravità oggettiva della violazione
Nel caso di specie, la Corte ha ridotto la sanzione a 40.000 euro, considerando l’abnormità dell’importo originariamente irrogato rispetto alla capacità finanziaria dei soggetti coinvolti e l’assenza di precedenti violazioni.
Il rapporto tra omessa verifica e omessa segnalazione
La sentenza chiarisce il rapporto tra le diverse tipologie di violazioni antiriciclaggio, stabilendo che l’omissione o l’incompleto adempimento agli obblighi di verifica della clientela costituisce l’antefatto dell’omessa segnalazione quando sussista nesso causale. In tali casi, trova applicazione la sanzione per l’infrazione più grave ex articolo 58, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Massime di diritto
Dalla sentenza in esame si possono estrarre le seguenti massime di diritto:
Prima massima: In materia di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all’art. 41 del d.lgs. 231/2007 grava sul legale rappresentante della società fiduciaria quando non sia stata istituita un’organizzazione interna della funzione antiriciclaggio con individuazione di soggetti delegati, non essendo all’epoca dei fatti del 2009 obbligatoria la costituzione di un presidio antiriciclaggio interno.
Seconda massima: Nelle operazioni di scudo fiscale ex art. 13-bis del D.L. 78/2009, l’esenzione dall’obbligo di segnalazione opera esclusivamente per i reati tributari specificatamente indicati dalla normativa e per le condotte di falso, rimanendo validi gli obblighi di segnalazione per illeciti diversi da quelli richiamati, anche quando i motivi di sospetto emergano successivamente al perfezionamento delle operazioni di rientro dei capitali.
Terza massima: Il concetto di sospetto di riciclaggio non è subordinato all’evidenziazione di un quadro indiziario specifico né all’esclusione dell’estraneità delle operazioni ad attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità delle operazioni ad essere strumento di elusione delle disposizioni antiriciclaggio, considerata la funzione di mero filtro delle segnalazioni e la ratio preventiva della normativa.
Quarta massima: La determinazione della sanzione deve considerare l‘assenza di precedenti, la collaborazione prestata e la capacità finanziaria degli incolpati, non potendo assumere funzione meramente preventiva di futuri illeciti.
Conclusioni
La sentenza della Corte d’Appello di Roma 12/2024 rappresenta un contributo significativo all’interpretazione della normativa antiriciclaggio, fornendo chiarimenti importanti su aspetti di particolare complessità tecnica. L’approccio della Corte, orientato verso una valutazione equilibrata tra esigenze preventive e principi di proporzionalità, offre utili indicazioni per la prassi applicativa.
La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato che privilegia la funzione preventiva della normativa antiriciclaggio, pur nel rispetto dei principi generali del diritto sanzionatorio amministrativo. Particolare rilievo assume la precisazione relativa alle operazioni di scudo fiscale, che chiarisce definitivamente l’ambito di applicazione delle esenzioni previste dalla normativa speciale.